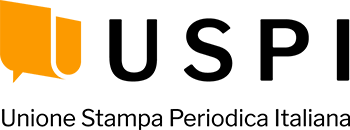Una passeggiata nel cuore della città eterna alla scoperta delle Mura Serviane. Un altro tassello della meravigliosa storia millenaria di cui siamo in qualche modo protagonisti.
Approfittiamo di questo periodo durante il quale viaggiare all’estero ci appare meno affascinante del solito per riscoprire o scoprire per la prima volta i tanti itinerari che la nostra bella Penisola ci offre, sia dal punto di vista naturalistico che storico artistico ed archeologico.
L’Italia è il paese, insieme alla Cina, con il maggior numero di siti iscritti nella World Heritage List dell’Unesco con i suoi 55 beni patrimonio mondiale dell’Umanità.
Iniziamo allora un percorso che ci porterà alla scoperta delle nostre radici e dei nostri fattori identitari per tornare ad innamorarci del Belpaese.
Il nostro viaggio non può che iniziare dalla capitale, Roma, unica città al mondo abitata senza soluzione di continuità, seppur con alterne vicende, dal X sec. a.C. ovvero da più di tremila anni.
E non possiamo che entrarvi dalla sua imponente cinta muraria: non tutti sanno infatti che Roma è circondata da ben 19 km di fortificazioni, considerate le più lunghe e meglio conservate al mondo fra quelle antiche.
Per proteggere la città eterna da attacchi nemici sono state infatti innalzate nei secoli ben due cinte murarie differenti, note come mura Serviane e mura Aureliane, dal nome dei governanti a cui si attribuisce la loro realizzazione.
La costruzione della più antica cinta muraria organicamente pensata, realizzata nel VI sec. a.C. in blocchi di cappellaccio, è considerata dalle fonti opera del penultimo re, l’etrusco Servio Tullio, da cui prende il nome, benchè secondo alcuni autori sarebbe stata iniziata già dal suo predecessore Tarquinio Prisco.
L’occupazione gallica del 390 a.C. mette in evidenza la debolezza di questa originaria difesa che viene riedificata, attraverso l’imposizione di un tributo alla cittadinanza, in “saxo quadrato” di tufo di Grotta Oscura, le cui cave erano a disposizione dei Romani in seguito alla conquista della città di Veio, avvenuta nel 396 a.C.
Tratti conservati delle mura serviane ci mostrano chiaramente l’esistenza di questi due momenti costruttivi principali, distinti essenzialmente in base all’utilizzo dei due differenti tipi di tufo denominati volgarmente “cappellaccio” e “tufo di Grotta Oscura”, mentre il tracciato delle due fasi coincide quasi perfettamente.
La lunghezza della rinnovata fortificazione raggiungeva quindi circa 11 km, racchiudendo al suo interno una superficie totale di circa 426 ettari. I numerosi cantieri che lavorarono contemporaneamente lungo tutto il percorso utilizzarono una tecnica costruttiva omogenea, assemblando filari di blocchi in tufo alti 59 cm, corrispondenti a due piedi romani, disposti alternativamente per testa e per taglio per un’altezza totale di circa 10 metri ed uno spessore che oltrepassava i 4 metri.
Reperti dell’antica cinta sono ancora oggi visibili in diversi punti della città, permettendoci di ricostruire almeno in parte il suo percorso: iniziamo allora la nostra esplorazione partendo da via del Teatro di Marcello dove possiamo vedere cinque filari in cappellaccio, appartenenti probabilmente alla fase più antica, sostenuti da un muro moderno. Due brevi tratti sempre in cappellaccio sono visibili alle estreme pendici del Quirinale, lungo la salita del Grillo, mentre nella vicina piazza Magnanapoli resta un tratto di quasi 10 metri di tufo di Grotta Oscura, che doveva appartenere ad una delle porte di accesso, la porta Sanqualis.
Mura serviane a piazza Magnanapoli 
Da qui la cinta seguiva la cresta del Quirinale, dove dovevano aprirsi altre due porte: la Salutaris, da collocare all’altezza dell’attuale via della Dataria, e la Quirinalis, in via Quattro Fontane.
Tratti notevoli delle mura in tufo di Grotta Oscura si conservano lungo via Salandra, all’interno del Ministero dell’Agricoltura e all’interno di alcuni edifici privati ; da qui le antiche mura, dopo aver tracciato un saliente di cui non resta nulla di visibile, viravano a sud, raggiungendo il luogo dove era collocata una delle porte più importanti della città, la porta Collina. Da questo punto iniziava il lato più debole ed esposto della città, il più pianeggiante, dove le mura erano state rinforzate da un agger, un terrapieno, da un muro di controscarpa con funzione di contenimento del terrapieno e da una fossa, raggiungendo, nella sua massima estensione, la considerevole profondità di 90 metri. Nei pressi di Piazza dei Cinquecento possiamo ammirare alcuni dei tratti più imponenti e meglio conservati delle mura serviane, in particolar modo quello posto a sinistra della facciata della Stazione Termini, lungo circa 94 metri, in tufo di Grotta Oscura. In questo tratto è possibile riconoscere i punti di sutura fra cantieri diversi dove i tratti eseguiti da ciascun cantiere vengono a contatto pur non combaciando perfettamente.
Tratto di mura serviane visibile nei pressi della Stazione Termini 
Proseguendo il nostro percorso, possiamo vedere lacerti di mura presso piazza Manfredo Fanti ed in via Carlo Alberto, dove era collocata la porta Esquilina.
Successivamente il percorso delle mura serviane diviene meno sicuro: troviamo dei resti in largo Leopardi ed in via Mecenate da dove proseguiva lungo colle Oppio, scendeva nella valle e risaliva poi verso il Celio dove, nei pressi della Chiesa dei Santi Quattro Coronati, dovevano trovarsi la porta Querquetulana e poco distante la porta Caelimontana, giunta fino a noi nel restauro augusteo come arco di Dolabella presso la Chiesa di Santa Maria in Domnica.
Brevi tratti sono ravvisabili in piazza Albania, mentre in viale Aventino abbiamo il tratto più notevole, dopo quello della Stazione Termini, lungo 42 metri; un altro settore importante è quello ancora visibile ad ovest di Santa Sabina all’Aventino in un sotterraneo adiacente alla chiesa, dove sono conservate tracce delle due principali fasi edilizie: in conci di tufo granulare grigio quella arcaica ed in tufo di Grotta Oscura quella successiva. Nel tratto compreso fra Piccolo e Grande Aventino si aprivano le porte Naevia, presso la chiesa di Santa Balbina; Raudusculana, su viale Aventino e Lavernalis a sud dell’Aventino, delle quali non ci è pervenuto alcun resto.
L’avvento al potere di Augusto e il conseguente periodo di pace decreterà la perdita di funzione del circuito murario, trasformando Roma in un raro esempio di città senza mura, fino alla costruzione delle cosiddette mura aureliane nel 271 d.C.
Dopo un lungo periodo caratterizzato dalla totale assenza di testimonianze relative alle mura serviane, ritroviamo le loro tracce nelle piante di Roma antica redatte a partire dal XV sec., mentre la riscoperta fisica di alcuni tratti di mura è dovuta soprattutto ai grandi interventi edilizi di fine Ottocento, che hanno trasformato radicalmente larghi settori della città, permettendoci di ammirare un altro tassello della meravigliosa storia millenaria di cui siamo in qualche modo protagonisti.
Proseguiremo domani con l’esplorazione del percorso delle mura Aureliane, prima di entrare nella città eterna.