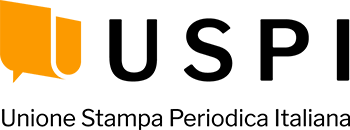Roma con i suoi vicoli riserva ad ogni angolo delle emozioni. I suoi monumenti ne testimoniano il passato, raccontano gli usi, le tradizioni e la cultura del suo popolo, riportandoci indietro nei secoli. Come il portico di Ottavia, complesso monumentale situato nel cuore più antico della citta .
Storicamente, gran parte della superficie del rione di Sant’Angelo, noto anche come Ghetto Ebraico, comprende il sito dove una volta si estendeva il grande Circo Flaminio, fatto costruire nel 220 a. C. dal tribuno della plebe Flaminio Nepote, l’homo novus, oggi diremmo un leader democratico, a cui si deve anche la via Flaminia.
Il circus, che occupava la zona attualmente compresa fra il teatro di Marcello, piazza Cairoli, via del portico di Ottavia ed il Tevere era, appunto, un edificio legato alla plebe, in cui si svolgevano i concilia plebis, le assemblee generali delle tribù plebee, ed i ludi per il popolo e che, come tutti i circhi di età repubblicana, consisteva fondamentalmente in un’ampia spianata, una sorta di spazio polifunzionale, dove si erigevano all’occorrenza delle strutture in legno.
Nel tempo, intorno al circo vennero costruiti una serie templi e portici, di cui restano tracce visibili nel famoso portico di Ottavia, che prende il nome dalla sorella di Augusto, a cui si deve il suo rifacimento, ma originariamente costruito da Q. Cecilio Metello Macedonico, intorno alla metà del II secolo a.C.Attualmente sono visibili il propileo, ovvero il porticato antistante le porte di ingresso, una sorta di vestibolo, un tratto di portico ed alcune colonne . Due colonne della facciata esterna sono state sostitute nel Medioevo da un arcone di accesso alla chiesa di sant’Angelo in Pescheria, sul cui architrave si può leggere l’iscrizione severiana del 203 d.C. che ne ricorda il rifacimento ad opera di Settimio Severo e Caracalla dopo un incendio del 191.
Il quadriportico, che racchiudeva i templi di Giunone Regina e Giove Statore, due biblioteche, una greca ed una latina, e un ambiente per le riunioni, la Curia Octaviae, era concepito come una sorta di galleria d’arte a disposizione del popolo con numerosissime opere, fra cui le 34 statue bronzee di Lisippo, rappresentanti Alessandro Magno ed i suoi cavalieri, provenienti dalla Macedonia come bottino di guerra di Metello e la statua in bronzo di Cornelia, la madre dei Gracchi, la prima rappresentazione di una donna esposta in pubblico.
Durante il Medioevo, la zona subisce trasformazioni importanti e il propileo di epoca romana viene utilizzato come percorso stradale, cimitero, sagrato della chiesa e mercato del pesce. Infatti nell’VIII secolo qui viene costruita la più antica chiesa a tre absidi conosciuta a Roma, Sant’Angelo in Pescheria, utilizzando per le fondazioni i grandi blocchi di tufo del monumento anticoe addossandone la facciata al lato posteriore del propileo. Nel giro di qualche decennio, poi, essendo ai tempi abituale la promiscuità fra vivi e morti. nella zona intorno all’edificio viene impiantato un cimitero che resterà in uso fino a tutto il XIII sec, quando la chiesa di Sant’Angelo conosce un momento di grande splendore, testimoniato dalla costruzione del grande arcone di accesso e dalla decorazione pittorica del timpano con al centro l’arcangelo Michele e sui lati la Vergine e un altro santo, di cui attualmente si possono vedere esili tracce.
La nuova struttura monumentale aveva il compito di valorizzare la chiesa, facendo convergere l’attenzione su di essa, perfettamente inquadrata nello spazio così definito, mentre il colonnato romano era relegato in secondo piano. Il nome Pescheria deriva dal mercato del pesce che vi si è tenuto a partire del Medioevo fino all’Ottocento, con l’esposizione delle merci sulle cosiddette pietre del pesce, affittate dai canonici del capitolo di Sant’Angelo, come ancora oggi testimoniato dall’iscrizione su una lapide ancora in situ, che recita n latino: le teste dei pesci più lunghi di questa lapide, pinne comprese, devono essere date ai Conservatori(amministratori capitolini n.d.r.)
Una documentazione storica senza precedenti di scorci urbani di questo ed altri luoghi romani oramai scomparsi, è costituita dalla collezione di acquarelli “La Roma sparita” di Ettore Roesler Franz, realizzati tra il 1878 e il 1896 esposta nel museo di Roma in Trastevere, visitabile gratuitamente in piazza Sant’Egidio, misconosciuto e prezioso scrigno di testimonianze della vita popolare e quotidiana romana.