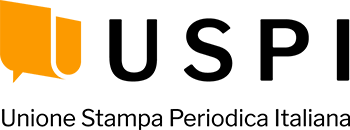Milano, 17 feb. (Adnkronos Salute) – “Non è stato facile e non lo è tuttora”, esordisce il direttore socio sanitario dell’Asst di Lodi, Paolo Bernocchi. E’ il giorno in cui gli anestesisti rianimatori guardano ai mesi trascorsi da quella notte fra il 20 e il 21 febbraio 2020, data in cui l’Italia scopriva a Codogno, in provincia di Lodi, il suo paziente 1 di Covid. E’ passato un anno da allora. Un anno in trincea per le terapie intensive del Paese. Non ultima spiaggia, ma “prima linea”. E proprio nell’ospedale di Codogno la società scientifica Siaarti (Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva) si è voluta riunire per una riflessione sulla pandemia, sui passi avanti fatti dal febbraio 2020 quando la Lombardia si è trasformata nella prima frontiera di lotta a Sars-CoV-2, scoprendo dall’oggi al domani che il virus era già in casa. Numeri incerti sui letti e le risorse disponibili nei reparti, una strategia e linee guida tutte da inventare: questa la situazione quando tutto è cominciato. Oggi la Siaarti guarda al futuro e lancia un progetto: un registro che permetta di monitorare le risorse a disposizione, i risultati che si ottengono. Per essere “pronti” anche all’impossibile. Quello a cui ha creduto la stessa Annalisa Malara, l’anestesista 38enne che il 20 febbraio 2020 a Codogno, vedendo un suo coetaneo con “polmonite devastante” non rispondere alle cure e “peggiorare inesorabilmente” a una velocità insolita, ha deciso di forzare il protocollo e disporre il tampone rivelatore.”Era una possibilità che ho ritenuto doveroso indagare – racconta oggi – perché se si fosse rivelata corretta ero consapevole che avrebbe avuto un impatto grande sul mio paziente e su gran parte della popolazione, come poi è stato. Noi anestesisti rianimatori siamo chiamati ad agire su pazienti che hanno bisogno di supporto per una o più funzioni vitali, in situazioni critiche in cui non c’è tempo da perdere e non possiamo permetterci di ritardare una scelta diagnostica”. E’ andata così per Mattia Maestri, paziente 1, oggi tornato alla sua vita con la moglie (allora incinta) e la sua bimba. I racconti degli specialisti si assomigliano: “Il 21 febbraio riceviamo la richiesta di aiuto di Codogno e da lì abbiamo iniziato a correre. E non ci siamo più fermati. Sulla strada che separa questi due comuni lombardi è nata la prima parte della rete”, ricorda Francesco Mojoli, direttore della Scuola di specializzazione in Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, Università di Pavia. “La prima esigenza è stata di chiudere Codogno, farci aiutare da Pavia e arroccarci su Lodi, perché un gran numero di anestesisti erano o positivi o contatti di colleghi positivi e domenica 23 febbraio eravamo con carta e penna a ridisegnare l’ospedale, abbiamo dovuto immaginare nuovi percorsi”, aggiunge Gianluca Russo, dirigente Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore Ospedale Maggiore Lodi/Codogno. “Altri grandi anestesisti sono venuti da noi nella nostra Rianimazione a rendersi conto delle necessità in loco e a darci una mano in termini di trasferimenti dei pazienti. Siamo riusciti a non soccombere e non siamo stati sopraffatti dal senso di impotenza perché siamo stati aiutati. Ora viviamo una fase diversa in cui stiamo cercando noi di dare aiuto” ad altre strutture e in aree oggi più in difficoltà. Nei giorni successivi allo scoppio dell’emergenza “si è deciso inizialmente di scegliere un numero limitato di ospedali hub”. Presto quei primi 130 letti messi in campo non sarebbero bastati più. “Avevamo capito da subito che era grave – osserva Giacomo Grasselli, coordinatore della Rete Ti Regione Lombardia – Il paziente 1 era un giovane senza particolari malattie”, in fin di vita, “che non aveva una storia di viaggi ma era un caso autoctono. E poi il giorno successivo i positivi erano già 36, senza legame con lui. Questo ci ha fatto capire che il numero di infetti che circolavano forse da mesi in Lombardia era più grande e che il fenomeno avrebbe assunto le dimensioni che poi abbiamo visto”. “Sapevamo, a dispetto di chi diceva il contrario, che non sarebbe stata una semplice influenza”, riflette Antonio Pesenti, direttore del Dipartimento di Uoc Anestesia-Rianimazione del Policlinico di Milano e coordinatore delle terapie intensive nell’Unità di crisi della Regione Lombardia per l’emergenza Covid. “Eravamo pronti? Non lo so. Ci siamo trovati con tutti i primari in Regione, abbiamo fatto dei piani che sono stati accettati. Quando i tecnici parlano con persone responsabili e propongono cose ragionevoli si riesce a lavorare. E alla fine durante la prima ondata abbiamo assistito nelle terapie intensive lombarde 4.900 pazienti con esiti simili o migliori rispetto a quelli di altri Paesi venuti dopo di noi”.Pesenti fa un accenno anche al ruolo degli specializzandi (“li abbiamo invitati a comportarsi da medici e questo hanno fatto”, dice) e sottolinea: “La terapia intensiva è stata, è e resterà molto importante”. Una lezione per il futuro? “Si deve considerare la possibilità di essere costretti a lavorare in una condizione di emergenza umanitaria. Credo che ci siamo andati vicini, specie in aree come Bergamo o Brescia, dove il territorio ha patito molto la malattia”, conclude l’esperto. “Abbiamo dato il massimo in un anno davvero impegnativo e vissuto sempre in trincea, senza risparmiarsi”, evidenzia Flavia Petrini, presidente Siaarti. “Due progetti ci stanno a cuore oggi. Si tratta del Registro-cruscotto delle terapie intensive italiane e del progetto Giorgio’s, iniziativa di raccolta dati volta a descrivere realtà strutturale ed operativa dei blocchi operatori degli ospedali italiani”. Il primo viene avviato da Siaarti per creare uno strumento unico di rendicontazione fra le Regioni e i centri ospedalieri dotati di reparti di Terapia Intensiva. Per consultazione e monitoraggio in tempo reale, trasparenza e aggiornamento quotidiano, ottimizzazione del sistema per la messa a regime degli investimenti strumentali e strutturali. Il progetto Giorgio’s (Gruppo italiano organizzazione e ricerca gestione integrata operativa) consentirà, se implementato su ampia scala, di capire qual è la riduzione/aumento delle attività chirurgiche nelle varie fasi di un evento come la pandemia in corso, e in tempi ‘normali’. Perché, conclude Petrini, è cruciale “poter disporre di quei dati necessari per una programmazione corretta delle attività” del Ssn.
‘Sapevamo che non era una semplice influenza, ora pensare al futuro’I racconti degli specialisti in prima linea, ‘travolti abbiamo fatto squadra’ Siaarti lancia 2 progetti da Codogno dove tutto è cominciato, ‘servono dati, sapere forze e risorse disponibili per programmare’
post precedente